Recensione del saggio di M. Maggioli ed R. Morri: “Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio“
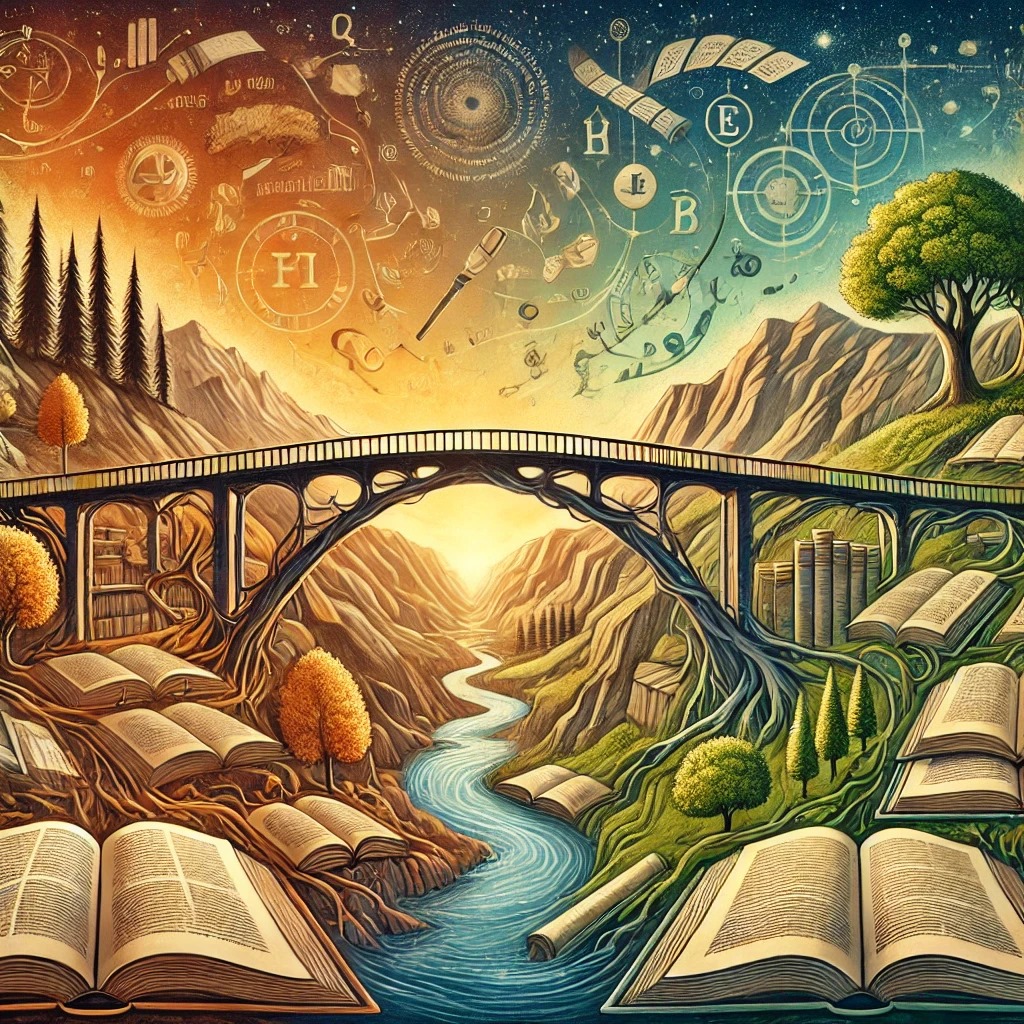
Il saggio “Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio“ di Marco Maggioli e Riccardo Morri affronta un tema affascinante e complesso: l’interconnessione tra due discipline apparentemente distanti, ovvero la geografia e la letteratura.
Maggioli e Morri iniziano il loro saggio sottolineando come la geografia, pur essendo nata come disciplina scientifica, abbia spesso tratto ispirazione dalla narrazione letteraria. Infatti, il testo sviluppa la tesi secondo cui la letteratura, prima ancora della scienza geografica, abbia avuto un ruolo fondamentale nel descrivere e dare senso ai territori.
Un punto centrale del saggio è la distinzione operata da John K. Wright con il suo concetto di geosofia, ovvero una “geografia della mente” che esplora non solo la descrizione scientifica del territorio, ma anche quella più emotiva e personale. Questa distinzione segna l’inizio di un lungo percorso che culmina, secondo Maggioli e Morri, negli anni Settanta, quando la geografia umanistica porta a una rivalutazione dello spazio come elemento centrale della narrazione letteraria.
Inoltre, gli autori spiegano come la rappresentazione dello spazio letterario nel XX secolo si sia evoluta, passando da un elemento di contorno, a una componente centrale e dinamica dell’opera. Citando Edward Soja e il suo concetto di terzo spazio (third space), evidenziano come la spazialità della vita umana diventi inseparabile dalle sue componenti storiche e sociali.
“La potenza della letteratura risiederebbe nell’operazione di coesione tra oggettività geografica e soggettività umana che, completandosi, contribuiscono a definire i luoghi e ad attribuirgli senso. In questa direzione, il rapporto geografia-letteratura può essere considerato come una sorta di memoria storica del luogo.”
Maggioli, Marco, and Riccardo Morri. “Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio.” Quaderni del ‘900, vol. 9, 2009, pp. 53-70. Fabrizio Serra Editore, p. 58.
Nel saggio, la letteratura assume una nuova dimensione in quanto non è più solo un racconto di eventi, ma diventa uno strumento per rappresentare lo spazio vissuto. Un esempio significativo è quello di autori come Pier Paolo Pasolini, che, attraverso opere quali Ragazzi di vita (1955), non solo descrivono luoghi, ma esplorano il loro significato simbolico e storico.
Un ulteriore aspetto trattato dagli autori è quello dei Parchi Letterari, che costituiscono una modalità concreta di congiunzione tra geografia e letteratura e sono considerati un’opportunità non solo per preservare il patrimonio culturale, ma anche per promuovere un rapporto più intimo e consapevole con il territorio stesso. I Parchi Letterari sono, infatti, una forma di “memoria storica” in cui il luogo diventa mediatore della relazione tra il soggetto e il territorio.
Un punto di forza del saggio risiede nell’ampia gamma di autori e correnti letterarie presi in esame in chiave interdisciplinare. Gli autori, infatti, non si limitano a studiare le opere di scrittori come Pasolini, ma ampliano la loro riflessione prendendo in considerazione le intuizioni di geografi quali Marc Brosseau ed Edward Soja. Questo approccio interdisciplinare consente di cogliere la complessità delle intersezioni tra geografia e letteratura, offrendo al lettore una visione completa e approfondita del fenomeno.
Per di più, “Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio” è un saggio che offre uno spunto di riflessione importante su come lo spazio e il territorio non siano semplici scenari, ma veri e propri protagonisti della narrazione letteraria. Per Maggioli e Morri la geografia diventa strumento di interpretazione del mondo attraverso la lente della letteratura, rendendo il testo interessante per chiunque sia appassionato alle interazioni tra queste due discipline.
Concludendo, ciò che potrebbe catturare l’attenzione dei lettori è il modo in cui l’incontro tra geografia e letteratura offra nuovi punti di vista per comprendere il legame dinamico tra l’uomo e il territorio, inteso non solo come ciò che ci circonda, ma come qualcosa che viviamo, raccontiamo e rappresentiamo. La geografia, spesso vista come una disciplina precisa e scientifica, viene arricchita dalla prospettiva soggettiva della narrazione letteraria, che permette di rivelare dimensioni più intime e personali del paesaggio. Il lettore potrebbe riflettere su come la sua percezione dei luoghi venga trasformata dalla letteratura. Dopo aver letto il saggio, potrebbe accorgersi che gli ambienti descritti nei romanzi non sono semplici scenari di sfondo, ma componenti attive che incidono sui personaggi e sulle loro storie. Luoghi come le periferie raccontate da Pasolini o le città rappresentate da Calvino diventano, infatti, riflessi e artefici delle dinamiche sociali e culturali che li attraversano.
De Gennaro, Alice, and Gioia, Rossana. “Tra luoghi e narrazioni: il ponte tra geografia e letteratura.” Recensione di Tra geografia e letteratura: realtà, finzione, territorio di Marco Maggioli e Riccardo Morri, Rivista Italiana di Geografia, Geolitterae.
